Dalla distruzione di Montecassino agli affreschi della scuola di Pietro Annigoni
di Iolanda Attanasio – storica dell’arte
 |
| Pietro Annigoni, Gloria di San Benedetto |
Nel febbraio 1944 ebbe luogo la distruzione di Montecassino ad opera delle truppe alleate. Precisamente, le operazioni di bombardamento iniziarono il 15. Gli americani ritenevano che l’abbazia fosse divenuta rifugio delle truppe tedesche, ma in realtà si trattò di un fatale, terribile errore di tattica militare: perirono centinaia (c’è chi sostiene migliaia) tra civili che all’interno del luogo sacro avevano cercato riparo, ritenendolo immune dagli attacchi, e probabilmente soldati tedeschi ed indiani – truppe numericamente inferiori a quanto ci si aspettasse.
La stessa valutazione di sicurezza aveva fatto sì che nei mesi precedenti numerose opere d’arte provenienti da Napoli e da tutto il meridione fossero trasportate nel monastero, ritenendolo un luogo sicuro per mettere al riparo tali beni dai bombardamenti che dal 1943 flagellavano quella parte d’Italia; successivamente però, qualche mese prima della drammatica distruzione, esse furono definitivamente spostate a Roma, proprio perché Montecassino non veniva più reputata tanto sicura.
Bombardamenti a tappeto andarono avanti incessantemente per tre giorni, dal 15 al 18 febbraio. Il tutto giustificato dall’idea che all’interno dell’abbazia si trovassero armi automatiche. Solo i basamenti delle possenti mura resistettero ai colpi incessanti: nel chiostro del Bramante solo la Statua di San Benedetto rimase in piedi, seppur gravemente mutilata.
Fortunatamente grazie all’abate Diamare ed al colonnello Schlegel della Divisione Göring molte delle opere d’arte e dei preziosissimi scritti amanuensi risalenti ai primi secoli del monachesimo, e patrimonio imprescindibile del monastero, poterono essere tratti in salvo perché nascosti nei sotterranei.
Ma, nonostante questo, le perdite risultano ad oggi ancora intollerabili ed inaccettabili.
Il grandioso monastero fondato nel 529 d.C. da San Benedetto insieme a suoi fedeli monaci da Subiaco aveva subito diverse distruzioni nel corso della sua storia: la prima nel 577 d.C. ad opera dei Longobardi, poi nell’877 dai Saraceni; in mezzo, il terribile terremoto del 1349. Ricostruita interamente nel XVII secolo in stile barocco napoletano, venne impreziosita dalle tele di Luca Giordano, Francesco Solimena, Francesco De Mura, Sebastiano Conca, nonché da sculture e sontuosi marmi policromi: non bisogna fare un grande sforzo di fantasia per quantificare le perdite occorse durante il bombardamento del febbraio 1944.
La ricostruzione iniziò piuttosto repentinamente, troppo forte era lo sconvolgimento subìto da uno dei luoghi simboli della Cristianità, a cui si aggiunse il martirio della città sottostante, ridotta ad un cumulo di macerie. I lavori presero il via nel 1948 ed andarono avanti per poco più di un decennio, finanziati completamente dallo Stato; nel 1964 Paolo VI consacrò la Basilica restituendola ai fedeli di tutto il mondo e nominando San Benedetto patrono d’Europa.
La cattedrale che vediamo oggi è il restauro di quella grandiosa opera progettata da Cosimo Fanzago a partire dal 1627, cui si faceva cenno prima, e consacrata alla fine del Settecento.
Con i lavori di restauro – più propriamente, di ricostruzione, utilizzando anche i più piccoli frammenti di detriti lasciati a terra dalle bombe – le sublimi decorazioni di marmi policromi vennero ricollocate, così come le altri parti in pietra, il coro ligneo, mentre sui soffitti delle navate vennero poste delle cupolette intervallate da pennacchi e lunette. Il tutto impreziosito da pregevoli cornici barocche intagliate e dorate. Ad oggi solo alcune zone, delle tante a disposizione, risultano affrescate: segno che la Basilica è una fabbrica in continuo divenire, un lascito ai fruitori moderni e ai posteri.
È proprio da qui che partiamo per raccontare del legame tra l’abbazia di Montecassino e la pregevole Scuola del Maestro Pietro Annigoni da Firenze, e di come poi questi artisti abbiano avuto un ruolo centrale nella storia della Galleria d’Arte “La Fenice”.
Risale alla fine degli anni Settanta la commissione all’Annigoni – celebre in tutto il mondo ed autore di importanti cicli di affreschi nel convento di San Marco a Firenze, nella chiesa di San Michele Arcangelo a Ponte Buggianese e, dopo quelli di Montecassino, nella Basilica di Sant’Antonio a Padova.
Annigoni è annoverabile tra i più importanti artisti figurativi del Novecento e soprattutto uno dei pochi nel mondo in grado di eseguire la tecnica dell’affresco sublimandola, studiando fedelmente i modelli dei grandi Maestri del Rinascimento. Consapevole egli stesso dei propri mezzi espressivi, amava ripetere: “I miei affreschi, i miei grandi olii, le mie acqueforti, resteranno in chiese, musei per i secoli a venire. Le invenzioni pittoriche tanto di moda oggi, sono invece destinate a finire nel niente, soprattutto se sono realizzate con la colla, pezzi di pane secco, lembi di stoffa…”. La sua fu una pittura sempre rivolta a stabilire un dialogo tra la natura e l’idea di essa, unita ad uno studio delle antiche tecniche non solo pittoriche (affresco, olio, tempere grasse) ma anche di stampa: ecco perché tra i suoi riferimenti troviamo Dürer, oltre a Pieter Bruegel il Vecchio, Holbein, e soprattutto Rembrandt.
Attraverso la tecnica egli dava vita a sontuose composizioni, che si facevano più drammatiche in certe scene di interni o paesaggi onirici, popolati da personaggi travagliati, evanescenti, in dialogo con una natura a tratti arida, ostile, che arriva a corrompere i loro lineamenti, a pietrificarne lo sguardo. Cosa che avviene anche negli affreschi di Montecassino, con protagonista un San Benedetto che deve vincere la morte con la fede, con la santità, con la bellezza che l’artista gli conferisce.
È opera sua prima di tutto la parete della controfacciata: dove una volta vi era una tela di Luca Giordano raffigurante la consacrazione della Basilica del 1071, Annigoni realizzò nel 1979 un affresco di 50mq, La Gloria di San Benedetto. Circondato da monaci, monache, vescovi e figure fondamentali per la storia del monastero (tra i quali sono riconoscibili, in basso, S. Gregorio Magno, Paolo VI, S. Vittore III) il Santo si erge nella parte alta della composizione e, con le mani quasi giunte, è circondato da angeli e lampi di luce abbagliante.
 |
| Il grandioso affresco in controfacciata dell'Annigoni |
 |
| Gli affreschi della cupola, del tamburo e dei pennacchi, di Pietro Annigoni |
Altri lavori di Annigoni si trovano nella zona presbiteriale e sulla cupola: nei pennacchi di raccordo con il transetto sono raffigurati, personificati, I quattro voti monastici: obbedienza, castità, povertà, stabilità, mentre nel tamburo circolare oculi raffiguranti Santi fondatori di altrettanti ordini monastici[1] e nella volta quattro episodi legati alla Vita e Gloria di San Benedetto.[2]
 |
| Gli affreschi di Romano Stefanelli sul soffitto del coro |
Gli allievi di Pietro Annigoni che lavorarono con lui a partire dallo stesso periodo furono Romano Stefanelli e Silvestro Pistolesi. Al primo venne affidato a partire dal 1984 il soffitto della zona absidale, sul coro, e alcune porzioni sopra il grandioso affresco in controfacciata. La sua tavolozza è simile a quella del Maestro, tuttavia riscontriamo tonalità leggermente più accese ed una nitidezza più accentuata, quasi le figure avessero dei contorni più marcati.
Silvestro Pistolesi è l’unico ad aver lavorato nell’Abbazia anche in epoche successive. Risale ai primi anni Novanta il grandioso affresco nel Refettorio – area questa purtroppo non fruibile ai turisti, ma che chi scrive ha avuto la fortuna di vedere in corso di realizzazione, all’età di cinque anni – raffigurante la Cena in Emmaus, alto 3,5 metri per 9 di lunghezza. La scena si svolge all’interno di un portico immaginario, illuminato dalla luce della luna: coppie di colonne doriche dividono in tre zone la scena: al centro Cristo seduto alla tavola con due personaggi, a sinistra un monaco ed a destra altre figure in conversazione.[3]
Sempre al Pistolesi si deve la decorazione di una intera cappella nella navata sinistra, con tre grandiose pale d'altare (3 metri di altezza per 1,70 di larghezza). Sulla parete sinistra un meraviglioso chiaroscuro lascia intravedere solo la figura di San Paolo che scrive le lettere, mentre nell’opera sulla destra è rappresentato San Pietro in carcere, cui appare l’Angelo. Lo stupore nel volto accomuna il tema ai grandiosi esempi dei secoli precedenti, mentre l’attenzione dello spettatore è catturata primariamente dal rosso intenso dell’abito del Santo. Entrambe le pale furono realizzate nello stesso periodo dell’affresco succitato, mentre nel 2009, quindi in epoca recente, fu posta nella parete centrale la pala d’altare con l’Incontro tra i due Santi. Quest’ultimo si differenzia dai due laterali per un cromatismo più chiaro, segno di come la tavolozza dell’artista si sia schiarita nel corso degli anni.
 | |
| La Cena in Emmaus, affresco nel refettorio, di Silvestro Pistolesi |
 |
| Particolare de La Cena in Emmaus |
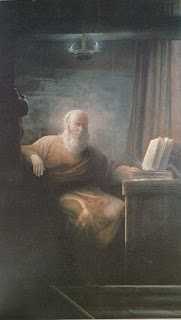 |
| San Paolo |
 |
| San Pietro |
Negli stessi anni – era il 1993 – veniva inaugurata, nelle immediate adiacenze del centro di Cassino, la prima sede della Galleria d’Arte “La Fenice”, in aperto dialogo artistico con l’abbazia. Avendo avuto modo di conoscere di persona Pietro Annigoni ed i suoi allievi mentre lavoravano nell’abbazia, il titolare Luigi Attanasio scelse proprio loro per dare inizio alle esposizioni, come testimonia la prima mostra inaugurale – una personale di Silvestro Pistolesi, seguita immediatamente da una di Romano Stefanelli. Tale scelta fu dettata soprattutto dalla voglia di far conoscere ai collezionisti tutte le espressioni artistiche della Scuola fiorentina, non solo le scene sacre dunque, ma anche composizioni, paesaggi, ritratti e nature morte, impreziosite dalla loro squisita – ed unica – tecnica della tempera grassa, recuperata dall’Annigoni da un’antica ‘ricetta’ rinascimentale, la quale ben si presta a raffigurare scene ambientate in un mondo visionario, immerso in ombre fitte in cui si muovono personaggi mitici o mistici, di stampo vagamente romantico.
Iniziò dunque nel 1993 la proficua ed ininterrotta collaborazione della Galleria "La Fenice" con la Scuola di Annigoni, divenuta nel corso degli anni qualcosa di più, una vera e sincera amicizia con i suoi artisti di punta.
(Continua venerdì 8 marzo...)
__________________________________________________________
Note
[1] S. Roberto, Abate fondatore dei Cistercensi; S. Oddone, Abate fondatore dell’ordine di Cluny; S. Alferio, Abate fondatore della Congregazione di Cava dei Tirreni; S. Guglielmo, Abate fondatore della Congregazione di Monte Vergine
[2]San Benedetto in gloria con la Vergine e S. Giovanni Battista; San Benedetto indica la sepoltura di S. Scolastica; Morte di S. Benedetto; Visione di S. Benedetto.
[3] In tutte le foto a disposizione si vedono solo due figure sulla destra, in realtà in epoca successiva ne fu aggiunta una terza in mezzo alle due preesistenti.
________________________________________________________
(Continua venerdì 8 marzo...)
__________________________________________________________
Note
[1] S. Roberto, Abate fondatore dei Cistercensi; S. Oddone, Abate fondatore dell’ordine di Cluny; S. Alferio, Abate fondatore della Congregazione di Cava dei Tirreni; S. Guglielmo, Abate fondatore della Congregazione di Monte Vergine
[2]San Benedetto in gloria con la Vergine e S. Giovanni Battista; San Benedetto indica la sepoltura di S. Scolastica; Morte di S. Benedetto; Visione di S. Benedetto.
[3] In tutte le foto a disposizione si vedono solo due figure sulla destra, in realtà in epoca successiva ne fu aggiunta una terza in mezzo alle due preesistenti.
________________________________________________________

